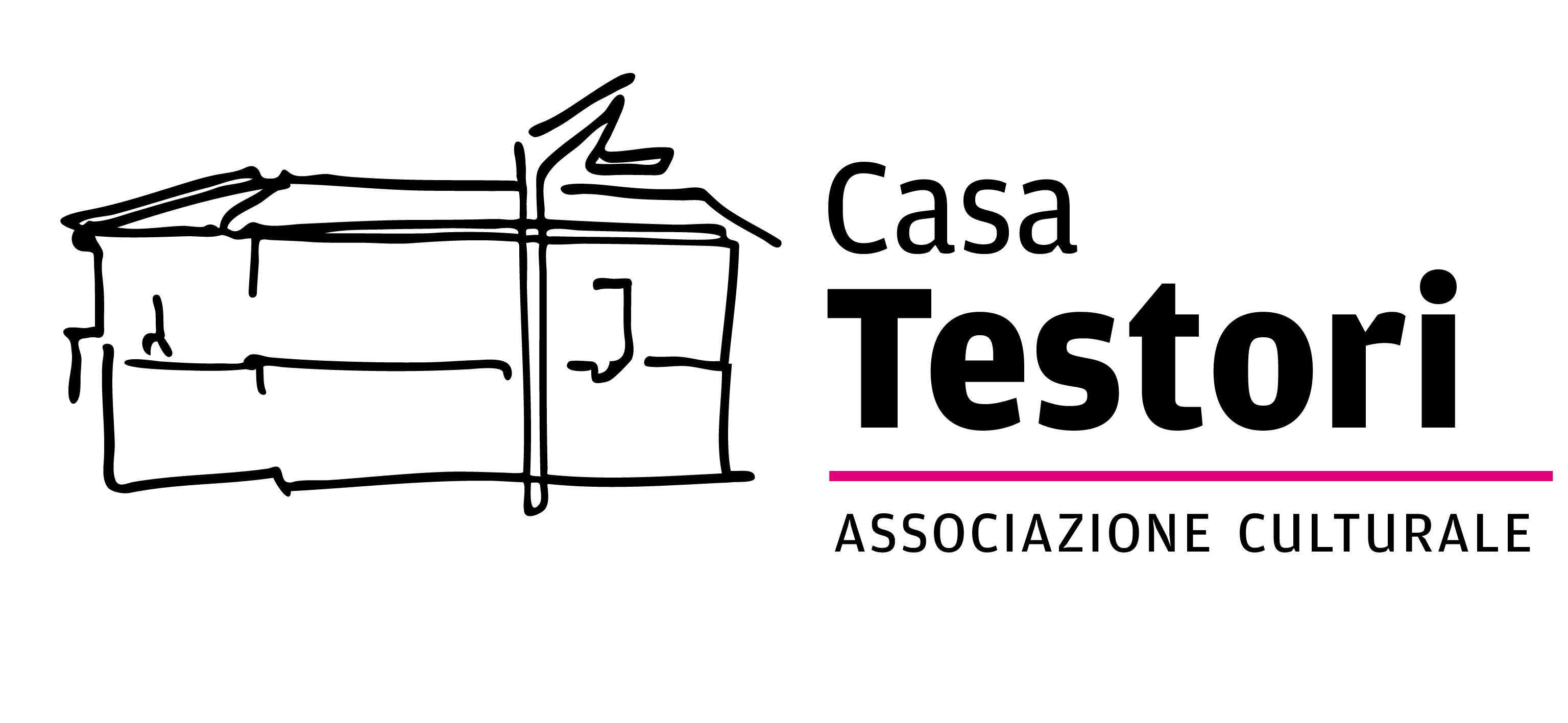Un progetto di Casa Testori
A cura di Davide Dall’Ombra, Luca Fiore, Giuseppe Frangi e Francesca Radaelli
Meeting di Rimini
20-26 Agosto 2015
UN SOLO TEMPO: IL PRESENTE
Giuseppe Frangi
Partiamo da un dato statistico: mai nella storia dell’uomo abbiamo avuto tanta produzione artistica come in questo nostro tempo. Mai ci sono stati altrettanti artisti, non solo come quantità assoluta (che sarebbe logico visto che siamo in sette miliardi sulla terra) ma anche come percentuale di persone che hanno scelto l’arte come propria strada. Perché c’è tanta voglia e tanto bisogno di arte? E come mai proprio in una stagione come la nostra, in cui la logica utilitaristica sembra sempre quella vincente? Sono domande per le quali vale la risposta che si diede Gio Ponti, raccontando un bellissimo aneddoto. Immaginava che Dio ricevesse alla fine dei tempi gli uomini ad uno ad uno, compiacendosi del proprio – suo di Dio – lavoro e di ciò che aveva creato. Quando dopo tutte le infinite professioni si presentò un artista, Dio restò interdetto. Perché, che gli uomini potessero essere artisti, era cosa che neanche lui aveva previsto. Ma invece che indispettirsi si compiacque ancor di più di quelle sue creature che avevano sorpreso il loro stesso creatore, facendo qualcosa che neanche Lui aveva messo in preventivo. Cosa suggerisce questo aneddoto? Che l’arte è l’attività che fa balzare l’uomo oltre se stesso, che è lo spazio dell’imprevisto, del non necessario, del gratuito. È il luogo in cui il desiderio che muove l’uomo in ogni istante della sua vita, tenta di oggettivarsi in una forma, in una parola.
È la stessa cosa da sempre, dal tempo delle incisioni rupestri di Lascaux sino ad oggi. Così come non c’è un tempo senza arte, non c’è neppure un codice che assicura sulla bontà dell’arte. Come ha detto Damien Hirst, uno dei fenomeni dell’arte contemporanea, personaggio insieme da scandalo e da copertina: «L’arte è vera se capisci qualcosa dell’essere vivi che non avevi mai capito prima».
Una cosa certa è che l’arte non può mai essere uguale a se stessa, deve accettare sempre il rischio del nuovo, del non detto prima. Anche a costo di fallire, di deragliare clamorosamente rispetto alla sua natura. C’è un’altra caratteristica dell’arte: conosce solo un tempo, ed è il tempo presente. Questo vale per sempre, nel senso che anche quando guardiamo una grande opera del passato, questa non è grande per statuto, ma è grande perché fa vibrare le corde del nostro presente, secondo uno sguardo che non è quello di nessun altro tempo della storia. E il presente dell’arte non è solo ideale, interiore, soggettivo. È anche oggettivo: The Artist Is Present si intitolava una straordinaria performance che ha emozionato centinaia e centinaia visitatori al MoMa di New York nel 2010. Marina Abramović, questo il nome dell’artista, per tre mesi è rimasta seduta davanti ad un tavolo, relazionandosi, soltanto a sguardi, con i visitatori che ad uno ad uno si sedevano di fronte a lei: 1565 persone per un totale di 700 ore di performance. Un’esperienza umanamente ed emotivamente intensissima, in cui l’artista consegnandosi allo sguardo dell’altro, in un certo senso “dandosi”, toccava qualcosa che aveva a che fare con il destino suo e di chi aveva di fronte.
L’artista oggi è difficilmente personaggio nell’ombra, perché i meccanismi mediatici sono molte volte parte integrante del suo agire. È personaggio che spesso è chiamato a scoprire tutto se stesso, a mettere a nudo la propria vita, come aveva fatto Tracey Emin, esponente della Young British Art, con un’opera dall’impatto mediatico clamoroso e dall’aspetto sconcertante: nient’altro che il suo letto sfatto, dopo essere stato “abitato” dal proprio corpo per quattro giorni, dominati da un istinto mortifero. Poi quando se ne è sottratta, ha visto in quella forma che racconta il potenziale disfacimento della vita un’immagine forte, una forma “scolpita” dalla vita stessa; dalla sua vita.
Ci si può chiedere a buon diritto come guarderanno quel letto gli uomini del prossimo secolo, che cosa ne vedranno. Ma l’idea che l’orizzonte di un artista sia quello di vincere il tempo, oltre che vagamente superba, è figlia di una retorica accademica che l’arte contemporanea ha avuto il pregio di spazzare via.
L’arte è uno strumento di relazione non pianificata con gli uomini di questo tempo. È un linguaggio che arriva a toccare corde profonde, con modi e tempi non preventivabili. Quando dal suo studio in Cina Ai Weiwei ha concepito l’installazione per il carcere ora in disuso di Alcatraz ha realizzato un’opera che si è rivelata un gesto risarcitorio, altamente poetico e quindi molto umano: l’aver riempito di delicatissimi fiori di ceramica bianca lavabi, vasche e anche water del carcere, suona come un omaggio a tutto l’umano che lì è stato profondamente umiliato. Quando Ron Mueck, scultore australiano di straordinaria abilità, monumentalizza le figure di due anziani bagnanti, compie un gesto profondamente spiazzante proprio perché carica di emotività e di commozione una situazione esteticamente non appetibile, e perché rimette al centro del fare arte l’eterno tema del corpo. È il tema su cui ha ossessivamente ed esplosivamente lavorato in tutti questi anni Jenny Saville, artista inglese. Lei che ha rovesciato sulle tele masse di fisicità strabordanti, una volta attraversata l’esperienza della maternità ha saputo raccogliere questa energia nella narrazione di una relazione: quella tra il suo corpo e i corpi dei suoi figli.
Il corpo entra in campo, per metafora, anche nella potente installazione di Anish Kapoor, artista indiano naturalizzato inglese. Con Shooting into the Corner (2008-2009) un cannone spara palle di cera rossa, materia quasi organica e grumo di sangue, contro un angolo della stanza, con una ritmicità implacabile, con violenza sorda e calcolata. L’effetto è impressionante, senza essere affatto teatrale. Un altro tipo di violenza è quella proposta da Alberto Garutti: una violenza luminosa, che abbaglia per far scattare una dimensione di meraviglia. Le 200 lampade che s’accendono ad ogni caduta di fulmine sul territorio italiano sono invito ad aprire una breccia nelle nostre menti, troppo urbanizzate e troppo calcolatrici.
Damien Hirst, Marina Abramović, Ai Weiwei, Ron Mueck e Jenny Saville, Anish Kapoor e Alberto Garutti sono i personaggi qui chiamati a proporre uno sguardo diverso sull’arte contemporanea. Uno sguardo curioso e aperto per non restare ostaggi dei soliti luoghi comuni. L’arte di oggi è certamente un abnorme fatto di mercato (al punto che uno dei più grandi e seri artisti di oggi, Gerhard Richter, si è pubblicamente detto imbarazzato delle valutazioni che le sue opere hanno raggiunto); l’arte è anche spesso stata ridotta a un idiota esercizio di nichilismo. Ma in mezzo a questa fanghiglia – come sempre nella storia dell’uomo – si possono scoprire dei “fili d’oro” che è un peccato non seguire, non guardare, non conoscere. Sono “fili d’oro” che raccontano un’imprevista, a volte spiazzante, commozione per l’umano. E che la raccontano in forme altrettanto impreviste, a volte molto diverse da quelle a cui la tradizione ci ha abituati. Ma l’arte non è obbligata da nessuna forma, anzi è nella sua natura uscire dalle forme anche del passato recentissimo e inoltrarsi su terreni nuovi, rispondendo alle sollecitazioni di tutto ciò che di nuovo la vita degli uomini mette in campo. «L’arte è una porta aperta alla possibiltà», ricorda uno dei più importanti curatori di oggi, Hans Ulrich Obrist, citando l’artista Leon Golub.
«Sono sempre stato interessato al momento creativo in cui ogni cosa è possibile e niente è ancora accaduto. Il vuoto è quel momento di tempo che precede la creazione, in cui tutto è possibile» risponde Anish Kapoor in un’intervista, incalzato dalle molte domande sulle sue forme concave e convesse e sulle opere di cera rossa che «si creano da sole». Questa mostra cerca proprio di seguire alcuni di questi “fili d’oro”, non attraverso le opere, ma la narrazione, anche spettacolare, di queste opere. Non vuole essere una scelta che cerca consenso, ma che sollecita curiosità. Prospetta situazioni che contengono anche un’audacia, con cui è affascinante fare i conti. Un’audacia di linguaggi o di approcci che porta gli artisti a inoltrarsi nelle fibre della realtà molto più di quanto a noi sia dato. A volte l’audacia è indotta dai mezzi che un artista si trova a disposizione: come è accaduto a David Hockney, grande artista inglese, che con l’arrivo dell’iPad ha capito di doversi arrischiare a dipingere sulla tavoletta, perché era una sollecitazione che gli avrebbe riservato sorprese. E, infatti, la bellezza delle sue immagini “artificiali” prodotte con i pennelli elettronici racconta di uno sguardo reso più acuto, più eccitato, più penetrato nella realtà.
È il modo con cui l’artista David Hockney (ma la cosa vale anche per tutti gli altri qui presentati) oggi tenta di continuare a stupire Dio.
LA MOSTRA
Uno sguardo curioso e aperto per non restare ostaggi dei soliti luoghi comuni. L’arte di oggi è certamente anche un fatto di mercato, spesso ridotta a puro esercizio di nichilismo. Ma in mezzo a questa fanghiglia – come sempre nella storia dell’uomo – si possono scoprire dei fili d’oro che è un peccato non seguire. Sono fili d’oro che raccontano un’imprevista, a volte spiazzante, commozione per l’umano. E la raccontano in forme altrettanto impreviste, a volte molto diverse da quelle a cui la tradizione ci ha abituati. Ma l’arte non è obbligata da nessuna forma. La mostra segue alcuni di questi “fili d’oro”, attraverso la narrazione, anche spettacolare, di queste opere. Lo spettatore era accolto da un video che introduceva, non senza ironia, il tema dell’arte di oggi, tratteggiandone alcune caratteristiche che la differenziano da quella dei secoli scorsi.
Vai al bookshop