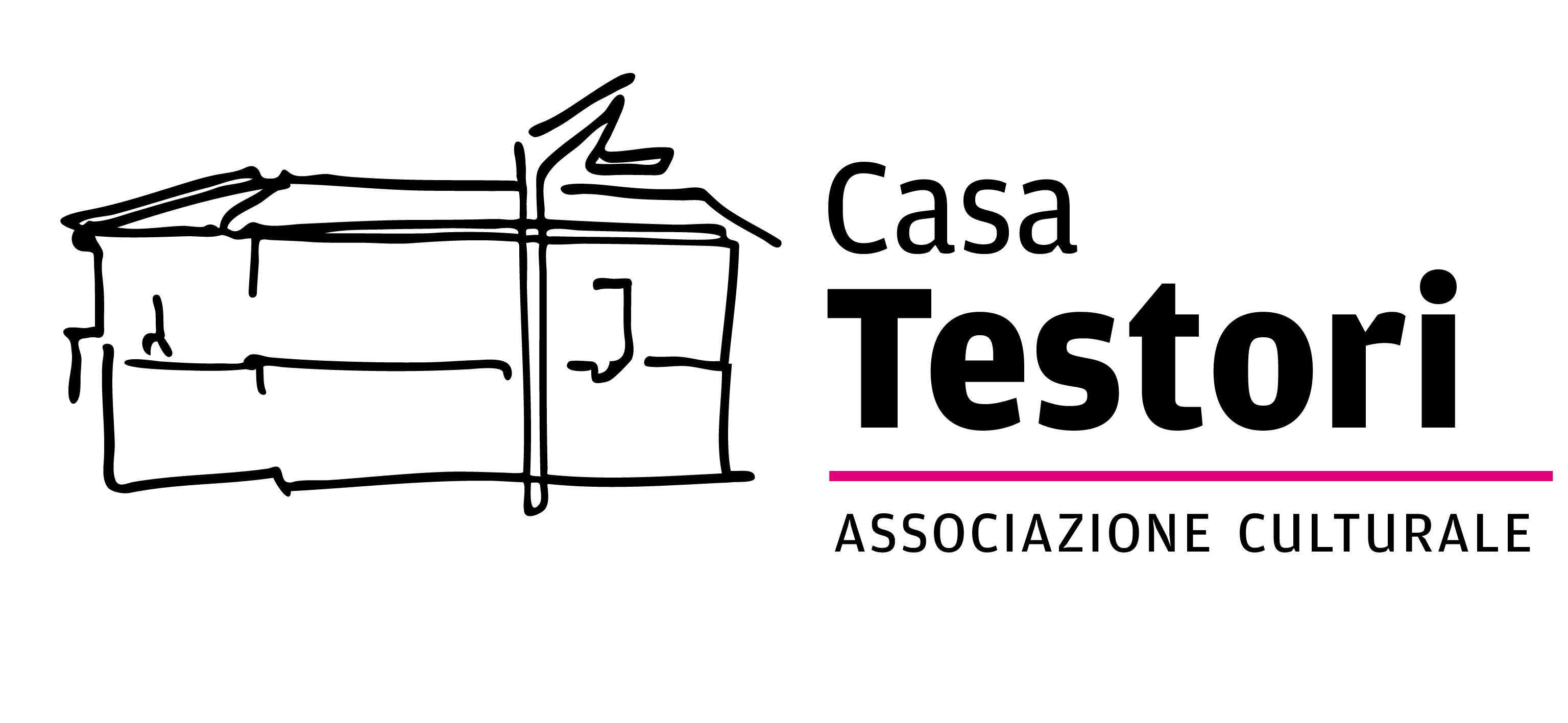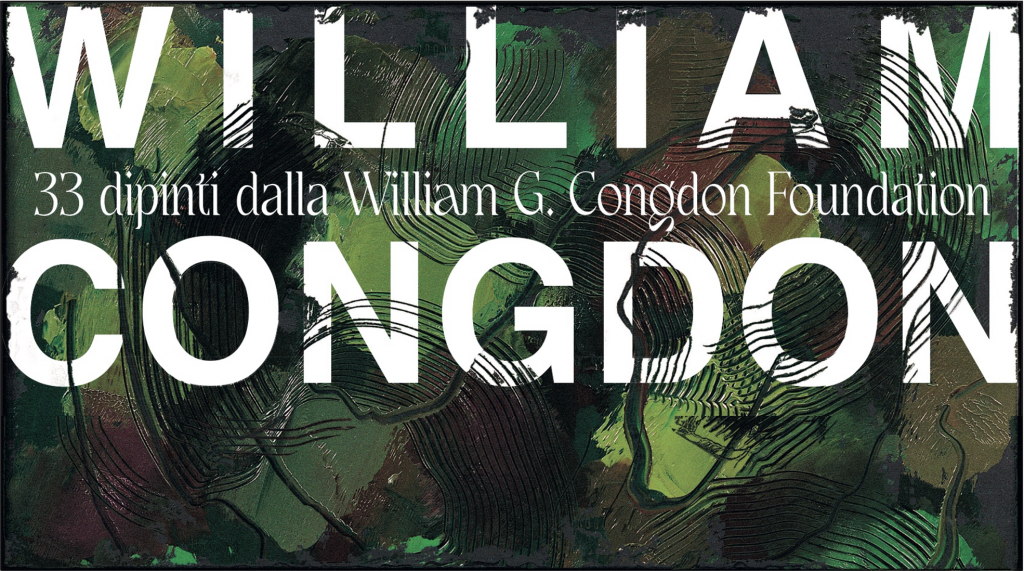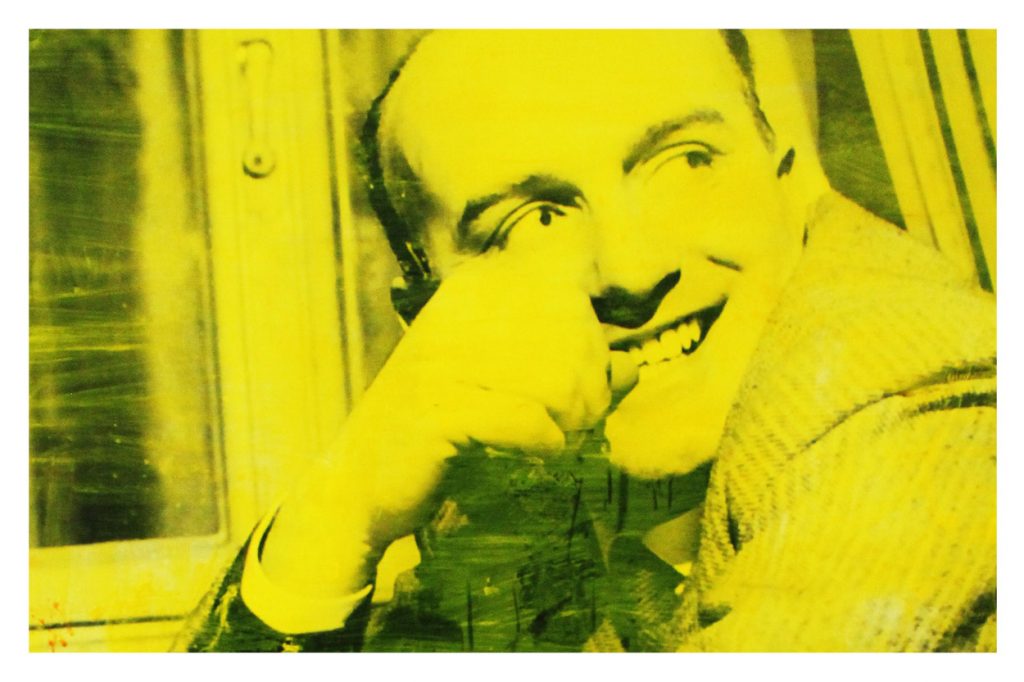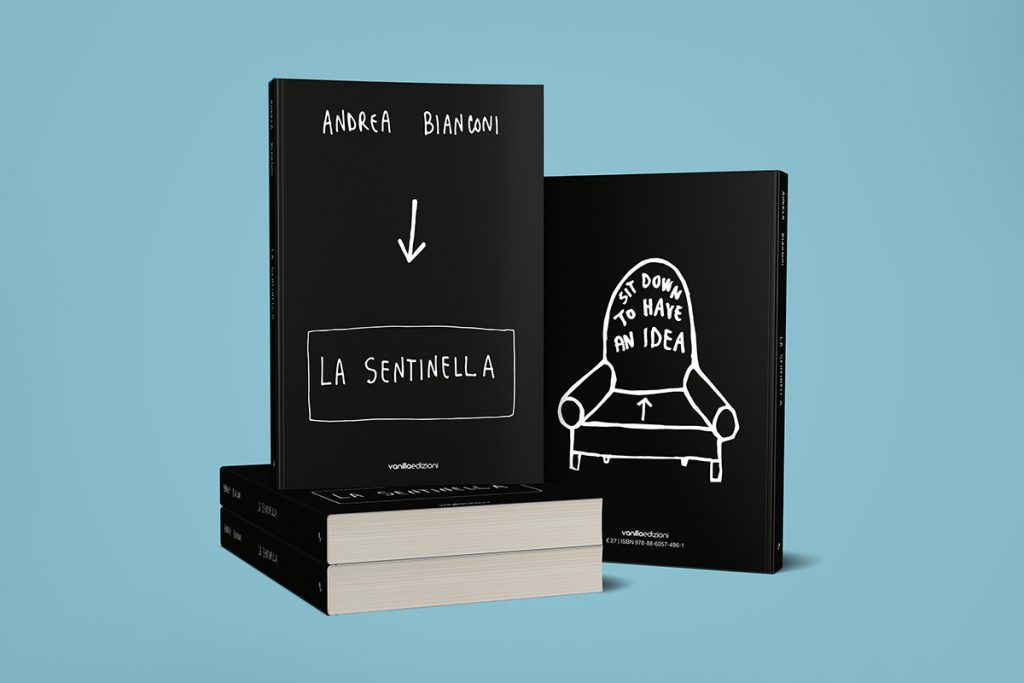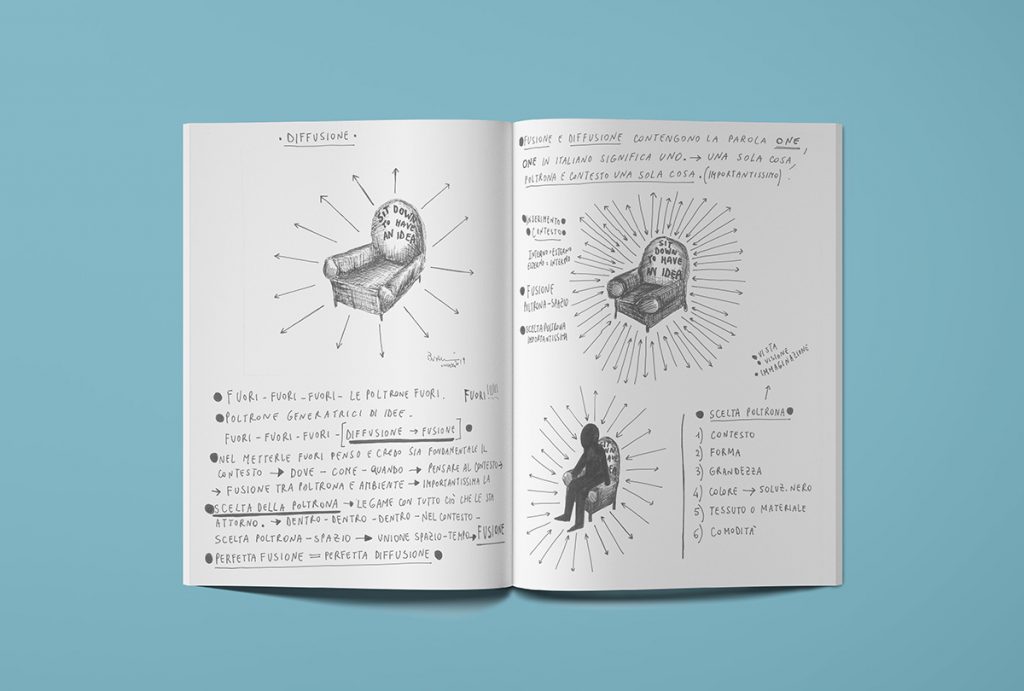“In questi mesi trascorsi a Casa Testori mi è stata data l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento di una realtà museale, partecipando attivamente”.
“L’esperienza di questi mesi mi sta fornendo strumenti utili e spendibili nel mondo del lavoro e mi sta formando anche a livello personale, nella relazione con i colleghi”
“Ho iniziato il Servizio Civile presso Casa Testori con lo scopo di lavorare all’interno dell’archivio testoriano e mi sono trovato fin da subito in un ambiente dinamico e stimolante, sia da un punto di vista personale che lavorativo”
“Lavorare a Casa Testori nel reparto dei Servizi Educativi è stata una grande opportunità per mettere in pratica le teorie e competenze apprese durante il mio corso di studi”
Sono le testimonianze di Matteo, Martina, Davide e Giada, i quattro giovani ragazzi che stanno svolgendo ora il Servizio Civile a Casa Testori.
Se hai tra i 18 e i 28 anni hai tempo fino alle ore 14.00 del 20 febbraio per candidarti al Bando del 2023!
Per il 2023/24, grazie al progetto ARTE DELLA SOSTENIBILITÀ, a Casa Testori cinque volontari affiancheranno lo staff per un’esperienza professionale di formazione a 360 gradi. In particolare, ciascuno dei cinque candidati prescelti afferirà ad una specifica area di competenza: Didattica, Archivio, Allestimenti, Comunicazione e Grafica.

Il progetto del Servizio Civile Universale “ARTE DELLA SOSTENIBILITA” fa parte del Programma ARTICOLO 9 – NELL’INTERESSE DELLE NUOVE GENERAZIONI che vede coinvolti l’Archivio Regionale dell’Educazione Ambientale dei Parchi lombardi (AREA Parchi) con numerose aree protette e alcune associazioni e enti del territorio, tra cui Casa Testori.
Sedi: Parco Nord Milano, Fondazione Cineteca italiana, Casa Testori, Parco Adda Nord, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
(leggi qui la SINTESI del progetto, le SEDI, il TESTO INTEGRALE)
COME PRESENTARE DOMANDA
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 20 febbraio 2023. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
b) Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Vedi anche gli approfondimenti sul sito del ministero:
– https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/
– Il bando: https://www.politichegiovanili.gov.it/media/lg2nbb0u/bando-ordinario_2021_13dic2021-signed.pdf
Per maggiori informazioni: areaparchi@parconord.milano.it – www.areaparchi.it
Scadenza: 20/02/2023