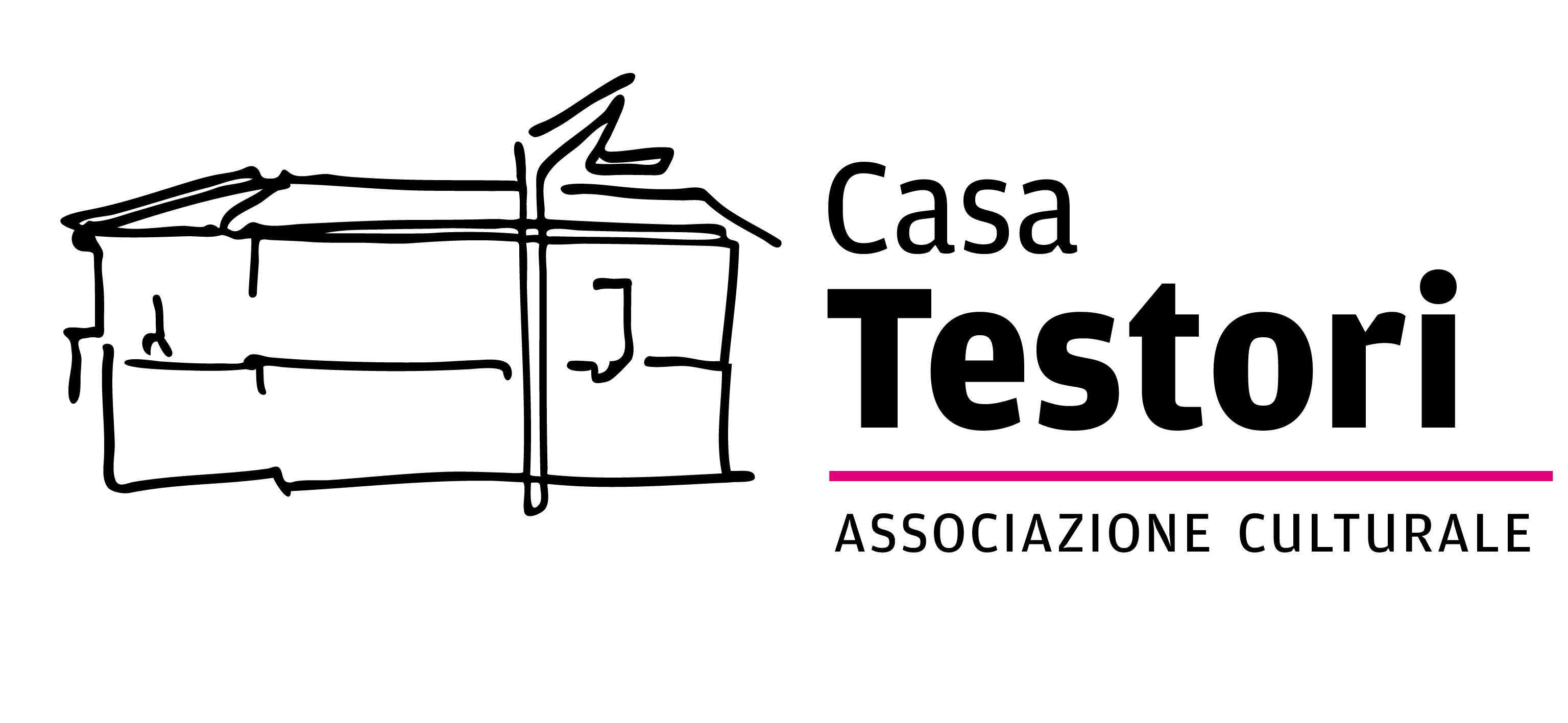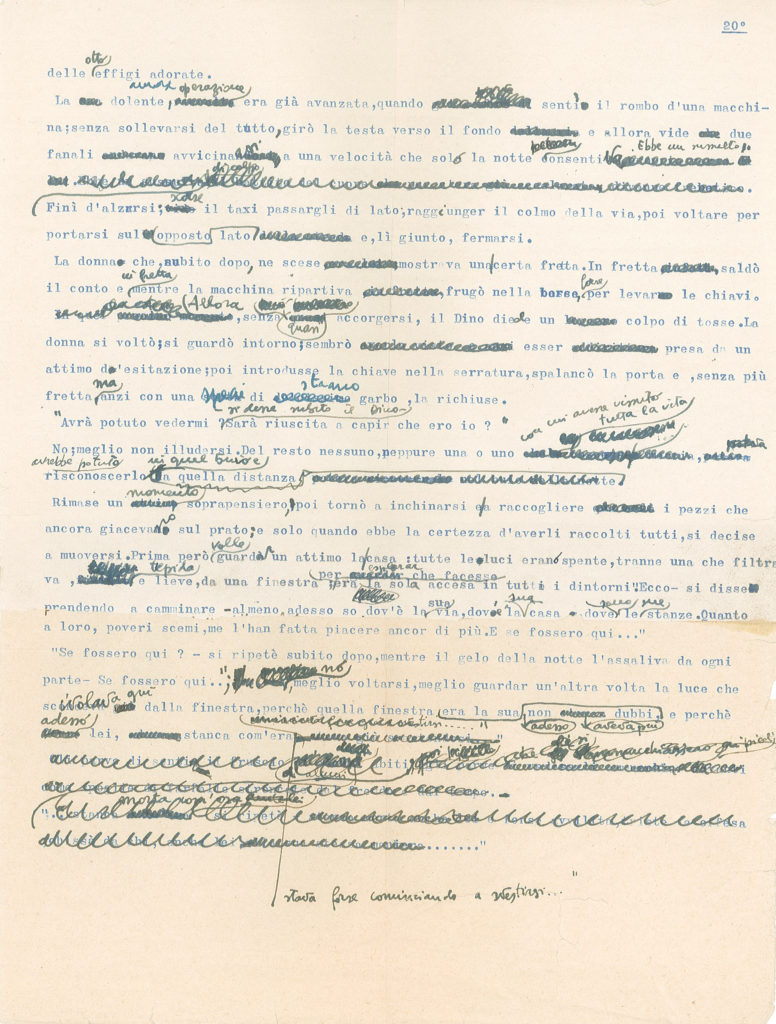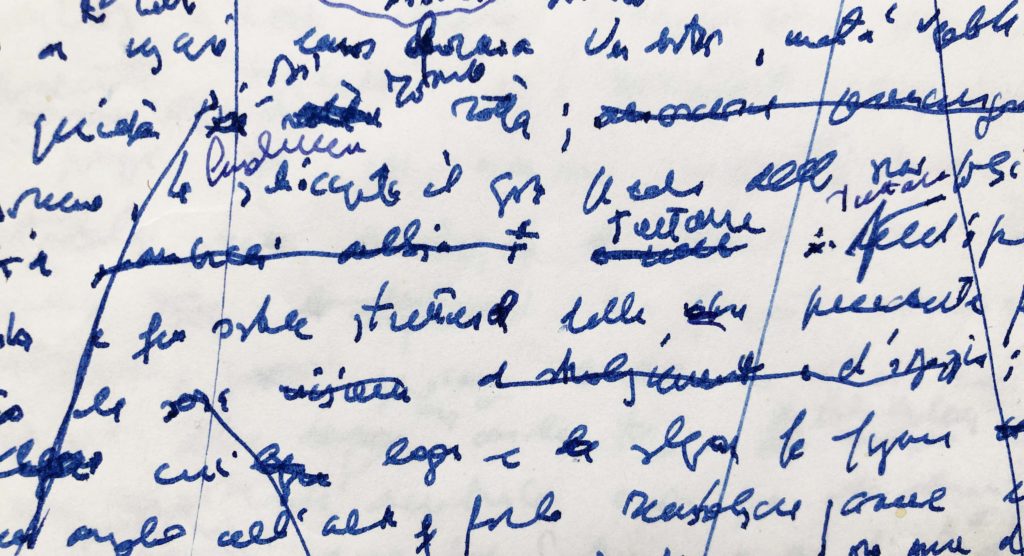Proponiamo qui di seguito il testo integrale della recensione di Giovanni Testori alla mostra “Caravaggio e il suo tempo” (Museo di Capodimonte, Napoli, 1985).
Napoli – Sacrosantamente gli esimi organizzatori di questa memorabile mostra («Caravaggio e il suo tempo», Napoli, Museo di Capodimonte, fino al 30 giugno), dove con ogni probabilità per l’ultima volta, è dato veder accostato un numero altissimo d’opere del Maestro, soprattutto quelle che s’usan chiamare «da stanza», han voluto dedicare la loro fatica a Roberto Longhi. La dedica risulta duplice. Essa non si ferma, infatti, alle parole con cui s’apre il Catalogo, nell’edizione italiana ancor meglio edito dall’Electa, ma si muove e vive, come linea prima e definente, nel pensiero critico di chi l’ha voluta, studiata e realizzata; soprattutto in quello di Mina Gregori che, oltre ad essere, con tutto il Comitato Scientifico, responsabile del disegno generale, s’è tenuta per sé il vero e proprio saggio introduttivo e la schedatura dei dipinti del tragico, supremo, atterrito, e, proprio per questo, continuamente risorgente protagonista; dando, in quest’ultimo ufficio, una prova da additare quale esempio, di come si possa tutto riferire di un’opera, tutto rispettare delle altrui opinioni, senza nulla sacrificare delle proprie. Non è piaggeria nostra se, a pochi giorni di distanza da quello che ci strappò, con quanta festosa gioia il lettore riuscirà forse a rammentare, per la mostra cremonese dei Campi, siamo indotti a ripetere qui, ulteriormente rafforzato, l’elogio per questa conoscitrice e «maestra» (detto nell’antico senso e nell’antica nobiltà del termine) della nostra storia artistica, che la maturità ha portato a offrire agli studiosi, ma anche all’onda vasta del pubblico, una così larga e profonda messe di frutti. Del resto, i temi delle due esposizioni risultano strettissimamente legati. È una civiltà, quella di Lombardia, che la Gregori ha inteso mostrare (o rimostrare) al mondo; accompagnando una sottilissima, indomita conoscenza critica a un senso, esso sì, veramente, democratico, di che una mostra ha da essere.
Dicevamo che la dedica longhiana diventa, qui, ripresa della tesi principe del grande critico. Ora quella tesi che, per alcuni anni, parve superata (ma, in effetti, non lo fu mai) dalle alchimie di letture astrattamente, quando non demenzialmente, iconologiche, torna qui ad essere totalmente onorata; e onorata perché il tempo ha mostrato quanto fosse pregnante e verace; e quali mai possibilità contenesse di venir sviluppata. Che è proprio quanto accade in questa mostra; e con tale ricchezza di conferme e d’aperture da farci affermare che, dopo l’irripetibile esposizione milanese del ’51, questa si pone come data fondamentale nello sviluppo degli studi caravaggeschi; anche per gli ardui ingorghi di problemi che propone, e che propone con la chiarezza e la drammatica lampeggiante violenza che il Caravaggio si meritava.
Prima d’addentrarci nelle magne sale di Capodimonte e riferire, almeno per come lo concede una pagina di quotidiano, convien dire che la sfilata dei capolavori risulta, già da sé, stupefacente: da quelli che compongono la sezione dei «precedenti» lombardi e che formano lo stormente albero genealogico del Merisi, a quelli dei bolognesi, dove s’alza a dominar tutti la straordinaria, sbilenca, sanguinolenta immersione «dialettale» d’Annibale Carracci che qui, con la «Macelleria», venuta da Oxford, espone il suo stato reale, prima che si genuflettesse al mito del classicismo; per arrivare, infine, a quelli dei contemporanei e degli immediatissimi seguaci, che di sovente risultarono immediatissimi traditori. Sono meraviglie, poste l’una accanto all’altra, ovvero l’una in opposizione all’altra, ma tutte necessarie, più che a far concerto di capolavori, a far storia; o a far storia con loro, i capolavori; e a dire come, nella fisiologica, carnale perentorietà della sua fatale e fetale coscienza lombarda, Caravaggio avesse occhi, mani, denti, labbra e intestini per tutto; e come, ove gli si mostrasse necessario, tutto rubasse di quanto altri aveva appena fatto o andava, allora, facendo; quasi che i quadri fossero per lui realtà, né più né meno di come lo erano gli uomini, le donne, i fiori, l’erbe, i frutti, i cavalli, i piedi, i ventri, i visi, gli sterni, le spalle e le cosce.
La copia e la ripresa sono azioni proprie ai talenti. Il furto, e non si crede di dire cosa nuova, è azione propria ai geni. Ma, in Caravaggio il furto non fu mai di stile; fu un fisico, erotico e persin losco interesse (ma sì, diciamolo pure, un losco interesse di parte; e come avrebbe potuto essere altrimenti in un uomo come lui?); fu, ecco, una fascinazione totalmente fisica e, insieme, psichica. Rubare a un’opera già fatta fu, per lui, come perder la testa, e non solo la testa, per il ragazzaccio, sconcio e divino, che si mise lì davanti a far da modello per l’«Amore vincitore»: o come addentare, con un sol colpo, la madida polpa di una mela.
–––
Famelicità
Siamo così entrati «in medias res»; e per direttissima. Ben più che proporre la nostra personale opinione su alcuni nodi attributivi e cronologici, opinione che la Gregori ci ha fatto l’onore di citare nelle schede (ancorché si tratti di pareri espressi, non già in studi specialistici, bensì e proprio da questo semplice giornale), ci preme avvisare di quanto, di rivoluzionario e travolgente, dalla mostra, s’evince; il che corrisponde esattamente a quanto, di rivoluzionario e travolgente, si dové evincere, ai suoi tempi, dalla carriera, brevissima e come fulminante in se stessa, del Merisi e dai modi in cui essa andò svolgendosi, come se dalla famelicità di vita, che inturgidisce di sé gli inizi, fosse stato chiamato a gettare la propria anima e il proprio corpo nella famelicità opposta: quella della morte. In pochi anni, a furia d’essere nella realtà (che conteneva, sia ben chiaro, una pressione sacrale tanto forte e tanto battente, lì, alle tempie, da permettergli d’essere proditoriamente ebbro ed erotico e, insieme, disastrosamente cosciente della propria perversa brama e della propria cupa e conseguente dannazione), il Caravaggio passò da una concorrenza strettissima e spietata, quasi da bocca a bocca, con la vita, a una concorrenza, non meno da bocca a bocca, e non meno spietata col sepolcro.
Ora il risucchio di quest’ultimo allunga le sue infinite, sfarinanti ombre sulal prima ben più di quanto questa non potesse stendere le luci d’alba, troppo densa, possente e carnale, sulla consunzione di quello. O, forse, sì, le stese; ma come strappando se stessa e facendosi laceratissimo lacerto serale; simile a quelli che appaiono all’orizzonte, sui profili stessi del mondo o negli occhi di chi abbiamo amato, prima che la notte ingoi tutto nel suo inesplicabile niente. Lo stile del Caravaggio, se talmente vuol davvero chiamarsi, ricava la sua rapidissima, fulminante suntuarietà, il suo disprezzo per ogni decoro, la sua ellitticità da supremo, tragico «imbianchino» dell’universo, proprio dall’istantaneità, e dall’inevitabilità, con cui tutto, in lui, s’accende, s’incendia e, poi, di colpo, rantola, si blocca lì e tace; in cui tutto si destina, d’ora in ora, di minuto in minuto, ad avvenire e a morire. Proprio perché l’avvenire coincide, in lui, sempre, con l’essere; proprio perché il nulla, nero, allibito e non più benedicibile da niente che sia umano, risulta, per lui, la sola testimonianza possibile del tutto; proprio per questo, l’immersione nella realtà fu, nel Caravaggio, quella che accade a chi, uscito dal grembo materno, delira per tornarvi e trasforma tutto in quel ventre; ventre che alla fine, si configurerà in un rantolo di tragica solitudine là, sulla desolata spiaggia di Porto Ercole.
È questa ventralità del reale, ventralità che la mostra napoletana ci ammonisce altra volta come trovasse la sua metafora espressiva, anzi la sua espressiva consustanzialità, iniziatica nei padri e nei fratelli (e nei fratellastri) di Lombardia, che rende possibile al Caravaggio compiere una sgominante sequela di paragoni coi maggiori esiti, non solo dei suoi contemporanei, ma dei grandi uomini del Rinascimento e finanche dei grandi d’evi più antichi. Paragoni che vivono, non sull’umiltà d’una coscienza impari, bensì sull’impudica, sfrontata certezza d’una coscienza assolutamente paritaria. Per restare al già citato «Amor vincitore», venuto a Napoli da Berlino, la sofferenza del Caravaggio non sta nel dubitare di reggere ai nudi della Sistina o agli strumenti musicali che la «S. Cecilia» di Raffaello si trova deposti ai piedi, gli uni e gli altri così golosamente, così clamorosamente visti, capiti, accolti ma poi, subito, rifiutati, anzi vomitati ed espulsi dal proprio corpo; sta nell’accettare, come fato suo proprio, quella sfrontatezza; e, soprattutto, nell’accettare il vuoto, inane a assoluto, che, subito, dopo l’esecuzione dell’opera, sembra aprirsi davanti a lui; come se ogni volta fosse l’ultima. Questo, finché, a furia di rapine operate sulla realtà, sulla storia e su sé medesimo, la volta sarà finalmente, e per davvero, l’ultima.
–––
Forma-azione
L’irripetibilità, e l’irrimediabilità, del «vero» caravaggesco, e della connessa cultura, risultano così atrocemente elementari. Non ammettono compiacenze. La coscienza della forma, in Caravaggio, non può stare altrimenti che nel suo realizzarsi; ma nel suo realizzarsi come se volesse distruggersi proprio e in quanto forma d’uno stile ed essere, invece, qual è l’enorme, povera, superba e derelitta realtà dell’universo in cui era stato espulso e in cui doveva pur respirare, vivere, agire e morire. La forma del Caravaggio risulta così azione; ma tale azione risulta, altresì, la sola coscienza possibile che dell’esistenza l’uomo può darsi e può, dunque, in qualche modo formulare. Tutto si passa in una velocità di tempi e di spazi che non lascia margine a niente che non sia il se stesso di quel preciso soggetto; dunque, di quel preciso dipinto. Mi pare che solo questo può permettere d’enucleare una formulazione, non troppo lontana e non troppo impropria, della sua pittura; e stabilire altresì i termini meno impropri per decidere dell’autografia, o meno, di un’opera. È alla luce, e alla tenebra, di questa verità eternamente attimale, o attimalmente eterna, non intuendo la quale ben poco può capirsi di che sia stata la rivoluzione del Merisi, che risulta, ad esempio, lecito dire come il problema relativo alle «Nature morte» dipinte nella bottega del Cavalier D’Arpino (problema magistralmente aperto dallo Zeri) non possa venir indebitamente evitato o, peggio, archiviato come van facendo tanti «estetisti» della critica d’arte, nostrana e non, ovvero che l’edizione veramente autografa del «Ragazzo morso dal ramarro», non sia da vedersi nell’esemplare inglese, qui esposto, bensì in quello, incomprensibilmente più diretto, ingombrante e «idiota» che fa parte della raccolta Longhi; ovvero ancora che, pur tenendo conto dello stato di conservazione e d’una pulitura assai prossima al delitto, la «Conversione della Maddalena» di Detroit, è pur essa copia e non già originale. Ed è sempre lo stesso metro, per dir così, istintual-coscienziale che ci assicura dell’assoluta, abbagliante e, insieme, cieca e come urlante autografia delle opere che la Gregori, da anni, in vari studi, è andata proponendo, conquistandosi una serie di meriti e, quasi, del caravaggismo, dopo le fondamentali restituzioni del Longhi, il primato. Non è luogo, qui, a nominarle, una per una. Basti forse citare, perché risulta la vera e propria rivelazione della mostra, il «Cavadenti», di proprietà delle Gallerie fiorentine, in deposito, ora, a Palazzo Montecitorio, che davvero non sembra sede per lui. Questo scorticante ed arso capo d’opera, in cui Caravaggio riprende e reinventa per tutti i pittori a seguire la «scena di genere», ma bruciandoli poi tutti, in quanto, più che d’un episodio di primitiva odontotecnica, sembra trattarsi d’un atroce, efferato assassinio, d’un turpe finale gesto di braccaggio compiuto da matrigna-la-morte, o la vita, che ora, e per davvero, fan lo stesso, sembra a noi porsi come un vero e proprio «test» per rassicurarci di chi abbia capito che sia stato, e sia tuttodì, il grande fuggiasco di Lombardia e di chi, d’averlo capito, finga; continuando a mettere in uso, per lui, proprio quelle misure formalistiche che lui aveva vissuto per distruggere. Aveva vissuto ed era, poi, così tragicamente morto. Ora, se con uomini come il Caravaggio poco lecito è scherzare, o sbagliarsi, quando si parli di vita, turpe e blasfemo è farlo quando si parli di morte: e del suo dopo.