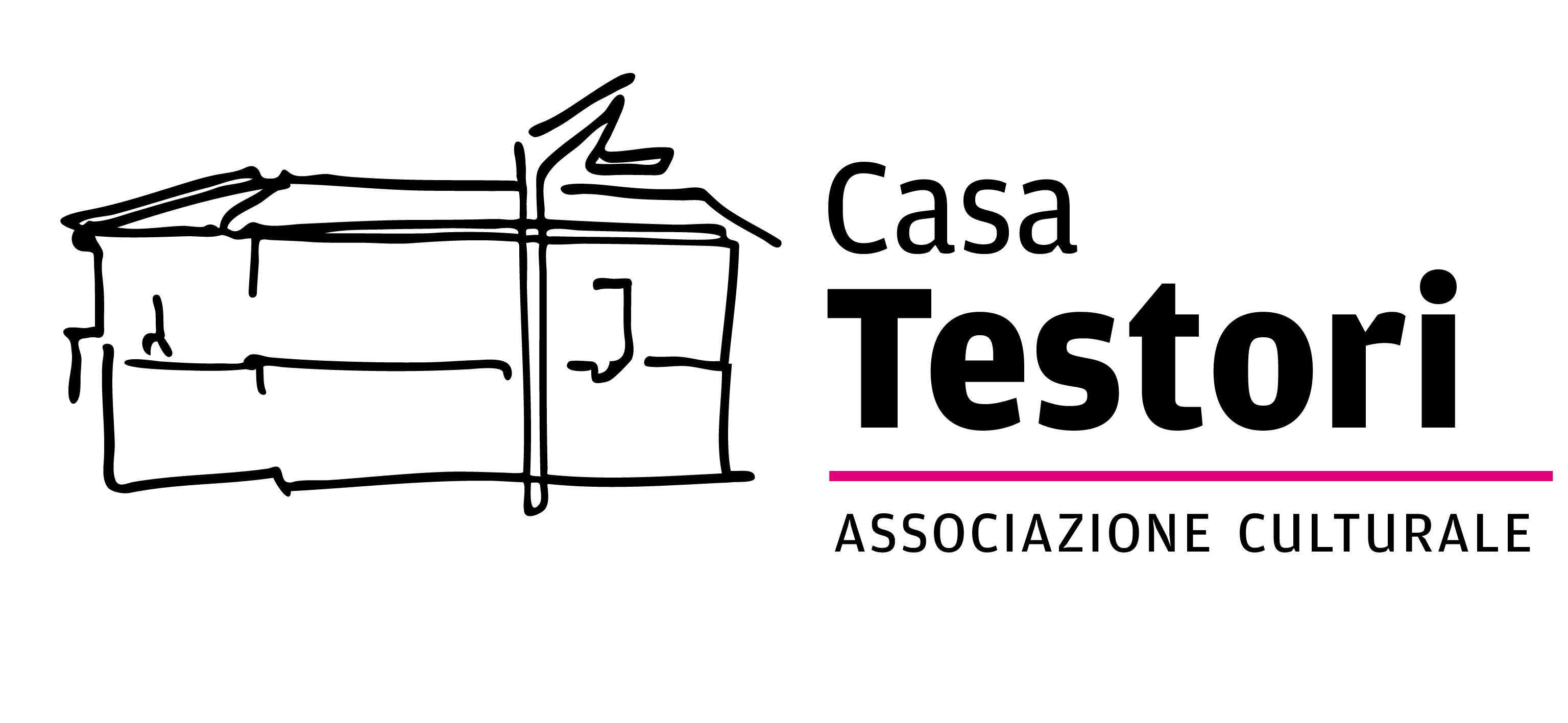Per accompagnarvi alla prossima visita guidata di Manet con Giuseppe Frangi (30 marzo, ore 21.15, Palazzo Reale) vi proponiamo un articolo di Giovanni Testori uscito in occasione della mostra del 1983 al Grand Palais:
A PARIGI GRANDE MOSTRA PER IL CENTENARIO DEL MAESTRO FRANCESE
Edouard Manet, impassibile e sublime
PARIGI – «Il n’y a qu’une chose vraie. Faire du primier coup ce qu’on voit. Quand ça y est, ça y est. Quand ça n’y est pas, on recommence. Tout le reste est de la blague»; per comprendere la sublime, impassibile grandezza con cui la pittura di Manet (1832-1883) prende campo dentro la storia dell’arte moderna, vi sale, anzi, uno dei troni più alti, e proprio da come essa nasce dalla splendida, visitatissima e, certo, irripetibile rassegna che Parigi ha voluto dedicare a Manet in occasione del centenario della morte («Grand Palais», fino al 1° agosto) convien partire dalle succitate parole, con cui il maestro era solito rispondere a chi lo questionava su cosa fosse la pittura; quella pittura da lui tanto adorata da essere la sua vera e propria amante, certo la sua vera e propria convivente.
L’enorme entusiasmo della folla che dopo oltre un secolo sembra risarcire Manet degli insulti che, dalla folla, gli eran stati riservati in vita, non sembra riguardare la critica; la quale, stando a quel che si legge soprattutto nel nostro ineffabile Paese, ha preso a tirar fuori i sui indispettiti «distinguo», i suoi complessati «sì, ma, però…» e le sue isteriche, zitellesche limitazioni. Sforzandoci di tener calmi i nervi noi possiamo anche capire; sembrandoci, nello stesso tempo, giusto avvisare come, mutate le condizioni e, in brevissima parte, le parole, la critica vada ripetendo l’incomprensione che riservò a Manet durante la sua esistenza. Possiamo capire, dicevo; non però, è certo, dare a tali letture una qualunque approvazione. Anzi, il fatto di comprendere i modi di tanto imbarazzo, ci autorizza a prenderci il diritto (e il dovere) di duramente dissentire. Possiamo capire, ecco, che il lavoro recente e recentissimo d’una certa critica, quella più «à la page» o che tale si vuole e per tale agisce (ma la pagina che conta non sarà, comunque e sempre, quella più prossima al vero?): quel lavoro è stato, in questi ultimi anni, di riportare in primo piano la pittura ingaggiata con la letteratura, di essa, anzi, così enfiata da essersi, come pittura, pressoché distrutta; maldestra e, spesso, insopportabile spugna inzuppatasi proprio di lei, «la blague».
Il suo intero percorso
Ora, rivedersi splanata davanti, nel suo intero percorso, una pittura come quella di Manet, del quale, parafrasando un poeta-poeta, potremmo dire che per sé volle «de la peinture avant toute chose», significa accettare di ribaltar i piani che s’eran creduti sistemati secondo la suddetta ottica; boccone, questo, non troppo facile da digerire. Meglio, allora, difendere le elucubrate e faticate costruzioni in cui le ideologie avrebbero maggior peso della realtà (quando tali siano; il che accade ben di raro); meglio questo, che non rimettere umilmente tutto in questione. Eppure… Eppure l’assioma sovrano, la legge inderogabile e splendente che Manet, dipingendo, quadro dopo quadro, stabilisce (o ristabilisce) per la pittura; quella sorta di decalogo indefinibile, stipato di sé come un immenso «gloria» laico, è lì; e si difende da sé; non inzuppandosi di nulla che sia alieno a se stesso: senza pretendere altro che il suo esistere; dunque, senza offendere alcuno; però mandando all’aria, con «le charme inattendu d’un bijou rose et noir», secondo ebbe a scrivere Baudelaire, tutte le cianfrusaglie che, alla pittura, furono laterali; e che laterali restano; con buona pace di chi vorrebbe costituirle invece come determinanti.
Diceva giustamente Cézanne di Monet «che era soltanto un occhio, ma quale occhio!»; affermazione che per altro deve un poco dimettersi, almeno per quel che riguarda l’ultimo tempo, ché allora proprio l’occhio, in Monet, forse per la già inoltrata malattia, parrà cedere alle richieste, assolutamente incongrue, ma circolanti un po’ dappertutto, del simbolo. Per Manet, la questione non fu mai di giustezza ottica; essa ebbe infatti a risiedere nella strutturazione della natura umana e di quella cosmica, in quanto riguardò, per così dire, la stessa necessità e decisione dell’esistere; dunque, la sua stessa, indicibile ragione; accolta, però, come tale; come tale, e basta. Che se poi all’occhio si volesse restare, si dovrebbe scrivere che, in Manet, si trattò d’una pupilla-cranio, d’una pupilla-mente.
Ciò che, visitando e rivisitando la mostra parigina, non cessa di stupire è l’attacco-distacco che, nei confronti della realtà, Manet seppe mettere in azione; e mantenere, poi, sino alla fine; l’attacco-distacco, intendo con cui la realtà, più che vederla, Manet ebbe a viverla; e, vivendola, ebbe a trasferirla sulla tela; tutto questo con una pienezza che non si conosceva dai tempi grandissimi del Velasquez. Si scrive questo, anche se qualcuno, cronologicamente, si attenderebbe, per restare in Spagna, il nome del Goya. Gli è che nel pur amatissimo Goya interviene, comunque e sempre, l’assedio d’un giudizio che obliqua la linea diretta che va dal visto al restituito; anche se proprio in questo abitò la sua enorme capacità di viraggio e di rivolta.
La pienezza della pittura di Manet risulta, invece, così densa di sé, di sé così certa e, inoltre, così splendente del suo essere niente più che se stessa e, dunque, di bastarsi, da trovare tutti i tesori necessari a farne il solo, esistente e supremo «elogio» che, nell’arte, la borghesia sia riuscita a darsi. Francamente, per una classe che giungeva proprio in quegli anni al suo apogeo di forza e d’opima, tesissima tranquillità, c’era di che sentirsi soddisfatta. E soddisfatta di sé, ma senza alcun compiacimento, si mostrò anche la pittura manetiana; la cui grandezza (e inimitabilità) ebbe a consistere nel semplicissimo, epperò rarissimo fatto che essa si pose là, sulle tele, come pura esistenza. Nessun lamento, nessun grido, nessun rimorso, nessuna vergogna; anche quando sull’orizzonte sembrò apparire l’annuncio d’un possibile crepuscolo, d’una possibile sera che andrà a screpolare la bellezza di carne, seta, petalo e perla; tato la borghesia, quanto il suo infallibile cantore mostreranno d’aver in sé tanta forza da annettere anche quell’annuncio all’opima potenza del proprio esistere.
Che, per far questo, Manet dovesse guardare ai grandi antichi, massimo ai veneti e agli spagnoli, non segna, come da più parti si tenta ancora oggi d’insinuare, una qualche incapacità a reggere il peso e il valore, enorme, di lei, la realtà, bensì la volontà di riferire e paragonare i propri strumenti all’arte passata, vista anch’essa come dominio della classe di cui andava edificando l’elogio; anzi, l’immenso, imperituro poema. Perché negarlo? Come la storia dei secoli più prossimi al suo trionfo doveva esser ritenuta dalla borghesia «naturaliter» accaduta affinché quel trionfo si verificasse, anche la pittura di quei secoli doveva rappresentare per Manet ciò che «naturalmente» stava dietro ai canti del suo poema. Suggerirla, quella storia, non fu altro che un modo per levarsi d’attorno «la blague» di chi, dissentendo, ovvero non riscendo a vivere nelle coordinate dell’attacco-distacco e nell’equilibrio dell’obiettività, faceva, e avrebbe fatto, anche della pittura antica, una questione; se, per l’appunto, i musei fossero da frequentare o no; fase prima della successiva proposizione, quella che avrebbe detto essere i musei cose da bruciare. Ma, alla fine, i musei chi li bruciò veramente? Quelli che piantarono sul viso della Gioconda i baffi o, invece, chi dai musei prese la forza necessaria per essere, prima di Picasso, l’unico, vero «classico» dell’arte moderna, e cioè lui, proprio lui, Manet?
Non è infatti a caso, che Picasso si sia attaccato, per esercitarvisi sopra senza fine, al «Déjeuner» di Manet (1863): giusto come si attaccherà a quella «summa» dell’arte velasquegna che sono «Las meninas». Difficile pensare che il grande spagnolo potesse rivolgersi, per la bisogna, all’altro «Déjeuner», quello di Monet, che del resto, senza il primo, giacerebbe del tutto inesplicabile.
Dunque, aveva ragione Malraux quando, a proposito della definitoria impassibilità che è nella «Fucilazione dell’imperatore Massimiliano» (1867) (qui, alla mostra, presente nel vastissimo abbozzo venuto da Boston) scriverà che «sempre il “Tre di maggio” di Goya, una volta che se ne siano tolti tutti i significati». Ora proprio in questo non soprammettere alla pittura significato alcuno abita, non sola la grandezza di Manet, ma la sua esplodente e come perenne novità. In questo abita altresì l’enorme apertura che Manet offrì agli impressionisti; un’apertura che è vano, se non già iniquo, mettere in discussione.
I fatti son lì da vedere: e da studiare. Ed anche è lì, da vedere e da studiare, il modo in cui l’oggettività di Manet arrivi intatta sino alla fine: cristallo dove il nero ha luce, potenza e gloria giusto come il bianco, la seta dei lutti come i petali delle peonie; e altresì il modo con cui essa non dimetta nulla di sé, anche quando l’avventura impressionista sembrerà minacciarla e superarla. Neppure a quella data, sarà Manet a guardare dove stiano andando, che so, Renoir o Monet; saranno Renoir, Monet e gli altri che, essendo partiti da lui una volta che Manet uscirà di scena, dovranno guardare (e, insieme, guardarsi bene) dal scivolare nel contrario di ciò che pure avevano stabilito come loro poetica.
In effetti la mostra titolata «Monet a Giverny» che, neppure a farlo apposta, Parigi offre in concomitanza al «Centre culturel de Marais» (fino al 17 luglio), pur nella sua incerta attribuzione critica e nella sua orrenda e psichedelica presentazione (ma, su questo, varrà forse la pena di tornare altra volta) è lì a provare che, morto Manet, anche il grandissimo Claude sembrerà mancare del termine di paragone diretto e, di lì a poco, versare in una commovente, ma non sempre chiara tentazione simbolista; dove la sua fulminante esattezza panica s’oblitera nelle ripetizioni proprie al decadentismo, assai più di quanto, come troppo spesso s’è scritto e si scrive, arrivi a perdersi e ad annegare nelle nebbie e nelle luci degli stagni e del cosmo. Cosa questa che c’era accaduto di segnalare alla mostra dell’80 e che il confronto odierno, davvero durissimo, che Monet è chiamato a sostenere per la compresenza dell’antologica di Manet, ripropone in termini allarmanti.
La gloria della pittura sembra determinarsi in Manet da sé; e per quell’abbandono alla grazia e alle seduzioni che solo possono darsi a chi, dell’abbandono, si sia vietata ogni possibilità; dunque, ogni connesso equivoco. In Manet, il dominio obbiettivo è il valore dell’immagine solo perché è valore della pittura; ma attraverso tale dominio, e solamente attraverso di lui, la pittura riguadagna tutti quei valori che il romanticismo aveva prima assalto e dissipato, poi strozzato e annegato nei pantani e nei laghi delle proprie estenuazioni e delle proprie stragi. «Figé» al suo se stesso, il mondo pittorico di Manet si potenzia essendo lì e, nello stesso tempo, staccandosi continuamente da sé; forse per la piena e concreta coscienza della brevità di cui quella potenza disponeva; almeno come atto di pregnanza e plenitudine totali.
Un regale distacco
In tal modo le figure della borghesia raggiunsero la fissità che ebbero i re e gli imperatori dun tempo; persino quella che fu propria alle antiche deità faraoniche ed egizie. Niente, dopo il Rinascimento, fu più fermo, stabile, attonito, addirittura decalogamente stabilito nell’esclusiva ed escludente legge della pittura, di quanto lo furono l’Olimpia, Nana, il Leon del «Déjeuner» di Monaco (1868/69) o quell’indicibile marmo-carne che è la «serveuse» del «Bar aux Folies-Bergère» (1881), opera con cui, si può dire, Manet chiude la sua carriera; e la sua vita.
Niente fu, di loro, più evidente, più chiaro e, insieme, più inesplicabile e misterioso. Noi, oggi, possediamo, con ogni probabilità, i mezzi per avvicinare e tentar di leggere, passo dietro passo, la biblica impresa di Cézanne o la tensione straripante, folle e profetica di Van Gogh, ma continuiamo a sentirci del tutto incapaci davanti a queste deità borghesi che ci incatenano trattenendoci a una distanza che par minima ed è invece smisurata. Dentro questa fissità, Manet ha deposto, con uguale, impassibile certezza, tanto la calma, frusciante perla della «Femme au perroquet» (1866) quanto quella peonia carnale che si disfa sui divani del proprio lutto, che è «La maitresse de Baudelaire couchée» (1862) o la «Berthe Morisot au chapeau de deuil» (1874), forse il ritratto più tragico che sia uscito dall’intero Ottocento.
Albe e notti, perle e onici, carni sode, levigate e fiori sfatti, sete e velluti, ombre e luci, tutto vive in Manet una pienezza che romba del suo semplice, stratificato e regale distacco. In tale pienezza, ogni quadro, quanto più sembra esibire ritorni all’antico, tanto più si sposta in avanti e annuncia ben altro di ciò che riusciranno ad annunciare gli impressionisti; questo, non solo nelle dimensioni dello spazio, ché Manet ebbe a interessare la pittura di tutto il mondo, ma anche nelle dimensioni del tempo. Se è vero, ed è vero, che la deificazione, più o meno legittima e legittimata, che della pittura l’arte moderna ha fatto come del valore primo e assoluto, trova la sua origine e lo specchio in cui riflettersi proprio nell’opera di Manet; uno specchio da cui, pel vero, dovrà spesso ritrarsi perché indegna; e, appunto, a questo in nulla legittimata. Tuttavia, la tensione resta quella; e, con ogni certezza, quella resterà ancora per molto e molto tempo.
Insomma, per chiudere con l’ex-libris pensato da Puolet-Malassis e inciso da Bracquemond: «Manet et manebit»; dove il gioco di parole sigilla, anche da fuori, di lui, Manet, la suprema obiettività, il supremo distacco e, nell’uno e nell’altra, la suprema, lucida grandezza.
Giovanni Testori