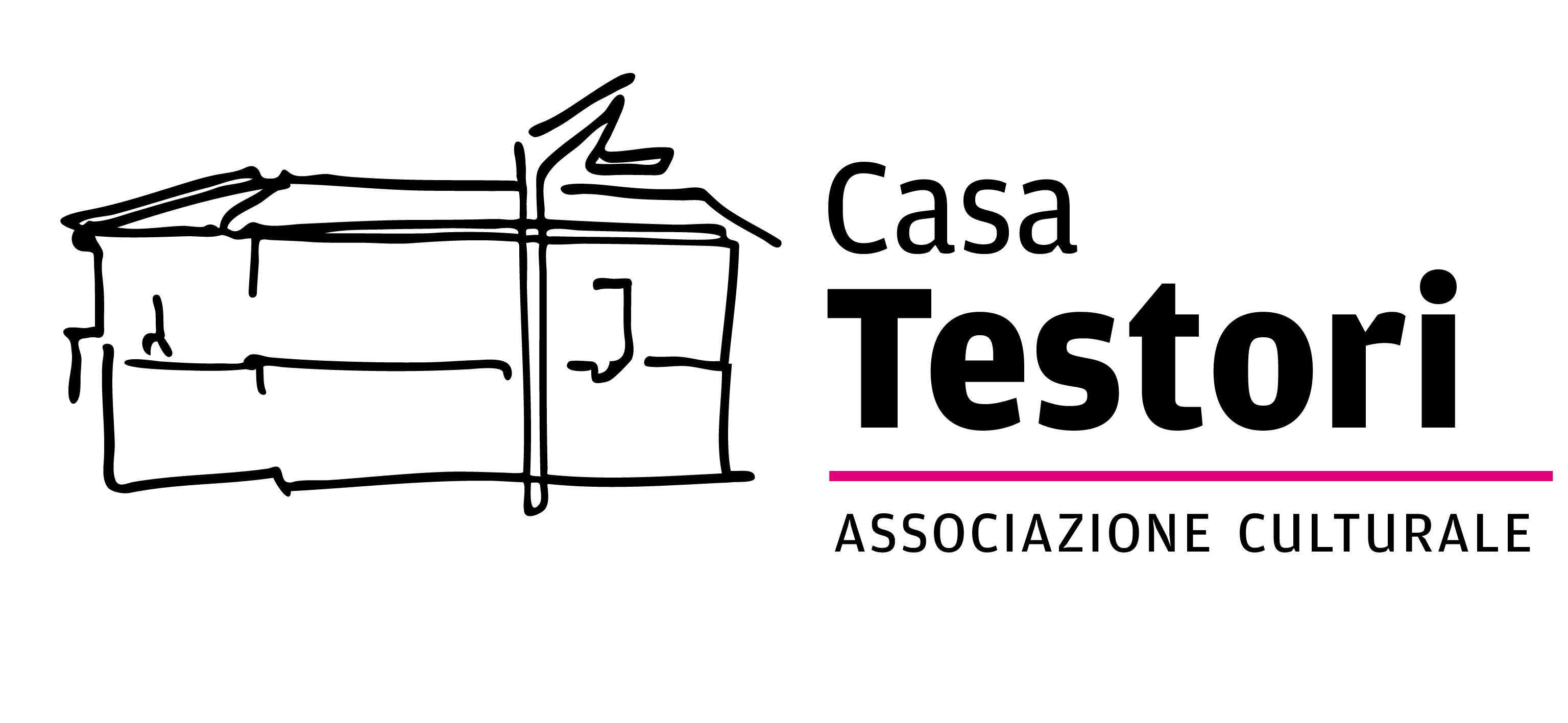Testori in carrozza
Lettura di pagine e poesie di Giovanni Testori sulla Valassina a bordo del treno delle 9.09 della linea Milano Cadorna-Asso.

Regia di Andrea Carabelli
Con Diego Becce, Claudio Lobbia, Antonella Morassutti
In occasione del Centenario della nascita di Giovanni Testori, Trenord in collaborazione con Casa Testori, lo celebra con una nuova iniziativa (dopo aver già realizzato l’evento speciale “Treno Testori” a maggio scorso) per promuovere la figura e l’opera letteraria dello scrittore, abituale utilizzatore dei treni della linea Milano Cadorna-Asso. L’iniziativa, coinvolge la corsa che parte da Milano Cadorna alle ore 09.09 e arriva ad Asso alle ore 11.30, per quattro sabati consecutivi tra giugno e luglio.
Nella carrozza centrale del treno si svolgerà un’azione teatrale: tre attori dialogheranno con i viaggiatori, raccontando il legame di Testori con quella parte di Lombardia e proponendo la lettura di sue pagine e poesie dedicate alla Valassina.
La cittadina comasca rappresenta un punto importante nella geografia dello scrittore: i suoi genitori erano originari della Valassina, e a questi luoghi Testori è sempre rimasto molto legato, tanto da ambientare qui alcune sue importanti opere, sia narrative che teatrali.
L’evento è gratuito e senza necessità di prenotazione; i viaggiatori in possesso di regolare titolo di viaggio potranno viaggiare nella carrozza di testa per assistere alla performance teatrale a bordo, fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.
DATE
17 e 24 giugno 2023
1 e 8 luglio 2023
Durata del viaggio: 1 ora e 20 minuti
Orario del treno (Regionale 625)
LA VALASSINA
A Sormano era nato suo padre, Edoardo. A Lasnigo sua madre, Lina Paracchi. Le radici di Giovanni Testori affondano tra le montagne e i boschi dell’amata Valassina. Il padre con il fratello maggiore Giacomo aveva avviato una piccola attività di follatura della lana nei pressi della casa di famiglia nella frazione Santa Valeria. Poi nel 1905, sulla spinta di uno spirito imprenditoriale tipicamente lombardo, avevano scelto di scendere in pianura per ingrandire la loro attività. Misero su casa e impresa alle porte della città, a Novate Milanese. Qui Testori sarebbe nato nel 1923, terzo di sei figli. Anche Lina era discendente di una famiglia di piccoli imprenditori tessili: i Paracchi avevano una filanda e torcitura della seta, là dove le acque del Lambretto che scendono dal Crezzo confluiscono in quelle del Lambro, che arrivano da Magreglio. Edoardo e Lina erano legati da una lontana parentela. Anche a lei accadde di venire a Novate a curare una zia, che era cognata del futuro marito, colpita giovane da un tumore. Lì si conobbero. E si sposarono nel 1919.
Fin da bambino, per Testori Sormano e Lasnigo erano “casa” non meno di Novate. Era accaduto nel paese della mamma l’episodio che ha sempre detto essere il primo ricordo della sua vita, datato all’incirca 1925: aveva assistito all’arresto di un uomo colpevole del furto di una mucca. Così lo raccontava: «Poi lui è passato avanti e io mi sono voltato; lui anche ha riguardato indietro e ha riaperto la bocca, ma era troppo lontano perché io capissi con meno imprecisione cosa avesse voluto dirmi… io mi ricordo quella bocca lì… e ogni tanto penso: “È ‘ciao’ che mi ha detto?”». Un interrogativo che lo avrebbe interpellato per tutta la vita. Sormano è invece legata all’esperienza da sfollato nel 1943; si era rifugiato con tutta la famiglia, mentre il padre e lo zio continuavano l’attività produttiva giudicata strategica. Era un Testori ventenne, ma già forte di tante relazioni di prim’ordine: tant’è vero che a Sormano accoglie anche il critico Mario De Micheli con la moglie, la cui casa di via Cerva era stata distrutta dai raid aerei, ed il grande pittore Ennio Morlotti, debilitato dalla malaria. Testori ricorderà tempo dopo: «Nel grande e indimenticabile stanzone di Sormano parlavamo di pittura, sempre di pittura, di tutte quelle cose delle quali ancor oggi parliamo».
La permanenza a Sormano è legata anche infatti ad esperienze artistiche: aveva dipinto una Pietà ad affresco che oggi è andata distrutta ma di cui esistono i disegni preparatori. Come pure si conservano due paesaggi realizzati nel 1944, certamente sotto l’influsso del naturalismo di Morlotti (che aveva 13 anni più di lui). Ma la Sormano di quegli anni è segnata soprattutto al primo impatto con la figura di Amleto, figura chiave per Testori: nella sua vita lo riscriverà infatti ben tre volte. Ecco come nelle Conversazioni con Doninelli ricorda quelle avventurose circostanze: «Insieme con altri ragazzi che si trovavano lassù con me, formai una compagnia. Il programma era ambizioso: volevamo allestire l’Amleto di Shakespeare presso il santuario di Campoé, che si trova in mezzo ai boschi. La scena fu posta tra due pilastri del cancello del santuario, con i fari di due automobili, dietro, che la illuminavano. Era piuttosto suggestivo, devo dire, nonostante la pochezza degli attori, soprattutto nella scena del funerale di Ofelia, che noi avevamo trasformato in una specie di processione. Con la resina degli alberi avevamo fatto delle torce, che demmo ai bambini della casa dei Martinitt lì vicina, a cui sarebbe andato l’incasso delle tre sere previste. Il cadavere di Ofelia veniva trasportato dal fondo della chiesa su una barella di fortuna, per cui gli spettatori videro avanzare questo corteo illuminato… Fu un successone. Non solo, fu anche il primo dei miei numerosi patatrac con la chiesa…». Infatti il parroco di Caglio dopo aver concesso il permesso lo aveva ritirato perché l’incasso non era destinato alla chiesa. Ci fu una vera sfida a suon di manifesti e di scomuniche dal pulpito, dove Testori, a suo dire, era stato additato come un «povero disgraziato».
Passa per le strade della Valassina la Coppa del Lago, la corsa al centro del primo romanzo di Testori, Il dio di Roserio, che si nutre di un’epica del ciclismo vissuta di persona tra il Ghisallo e il Muro di Sormano. È infatti tra i tornanti della discesa da Valbrona verso Onno che si consuma il misfatto del capitano della Vigor, Dante Pessina, nei confronti del suo gregario Sergio Consonni. E come dimenticare che proprio a Valbrona nella chiesa di San Michele Testori aveva scoperto il suo primo quadro di Morazzone, pittore del 600 lombardo al centro di tante suoi libri e mostre?
Col passare degli anni sarà molto più Lasnigo che non Sormano a sollecitare l’immaginario di Testori. Intorno al 1960 scrive un racconto, concomitante con il ciclo dei Segreti di Milano, La Maria di Barni, la cui protagonista era nata e abitante nel comune poco sopra Lasnigo, ma era stata dipendente della Filanda Paracchi. Per Testori è occasione per uno sguardo dall’interno di quell’ambiente a lui così famigliare: «…poi subito dietro quella voce ecco il fruscio del Lambretto: bastava alzare gli occhi dalle bacinelle dove i bozzoli nuotavano gialli e maleodoranti ed eccolo scender giù, rasente il muro della fabbrica, certi giorni pieno e rumoroso, altri secco e silenzioso, come se sulle montagne avesse prosciugato ogni linfa: il Lambretto».
Lasnigo è una sorta di ombelico del mondo per Testori. Quasi una Betlemme, come fa dire a suor Felicita, protagonista di Passio Laetitiae et Felicitatis, romanzo del 1976. Lasnigo, «la mia civis» rispunta inaspettata in tantissimi testi. Ad esempio in occasione di un articolo dedicato a Giorgio Morandi pubblicato sul “Corriere della sera” nel 1978: raccontando di un incontro con il grande pittore a casa di Roberto Longhi, Testori ricordava come davanti ad un quadro del maestro avesse rievocato sensazioni vissute nel paese della madre. A Morandi «sembrò bellissimo il nome, fin lì mai sentito, di quel paese; lo ripeté due, tre volte, strascicandolo alla bolognese “Lasnigo, Lasnigo…”». Il ricordo del Crezzo apre una recensione pubblicata sempre sul “Corriere” nel 1983 per una mostra di Mario Schifano. La chiesa romanica di Sant’Alessandro fa scattare a ripetizione memorie struggenti, come quella relativa agli affreschi nell’abside: «La cosa straordinaria, per me, era che il pittore, dietro le mura di Gerusalemme, aveva affrescato una valletta, con degli anfratti di roccia, che si vedevano da Sormano». Con un poetico ricordo di un episodio accaduto alla chiesetta di Valmorana, appena sopra il paese, si apre uno dei più bei testi dedicati ad Ennio Morlotti nel 1989.
Infine a Lasnigo e dintorni si consumano i “lamenti” di Cleopatràs («reina de Lasnig»), Erodiàs e Mater strangosciàs, le protagoniste dei Tre lai, l’ultima opera di Testori, forse il suo capolavoro. Ma in questo caso il debito non è più soltanto “topografico” ma anche linguistico. Il suffisso in “às” che sigilla i loro nomi è derivazione poetica infatti dalla “as” che sta al centro sia di Valassina, di Asso, che di Lasnigo. Come canta la regina nel primo dei Tre lai, «non Cleopatràs / arei voruto me ciamàs,/ bensì, l’Assàs!”». E poi davanti alla vista della capitale del suo sgangherato regno: «te revedo,/ anz’anzo, ecco, te tango/ o mia civis de Lasnigo!/ Te vedo/ e squasi, io da me sola, eccota, piango…/ Sei te,/ sei te!». Per poi arrivare ad una definizione che è come un sigillo: «Mia civis,/ te,/ carnascial substanzia». E qui Testori sta più che mai dicendo di se stesso.