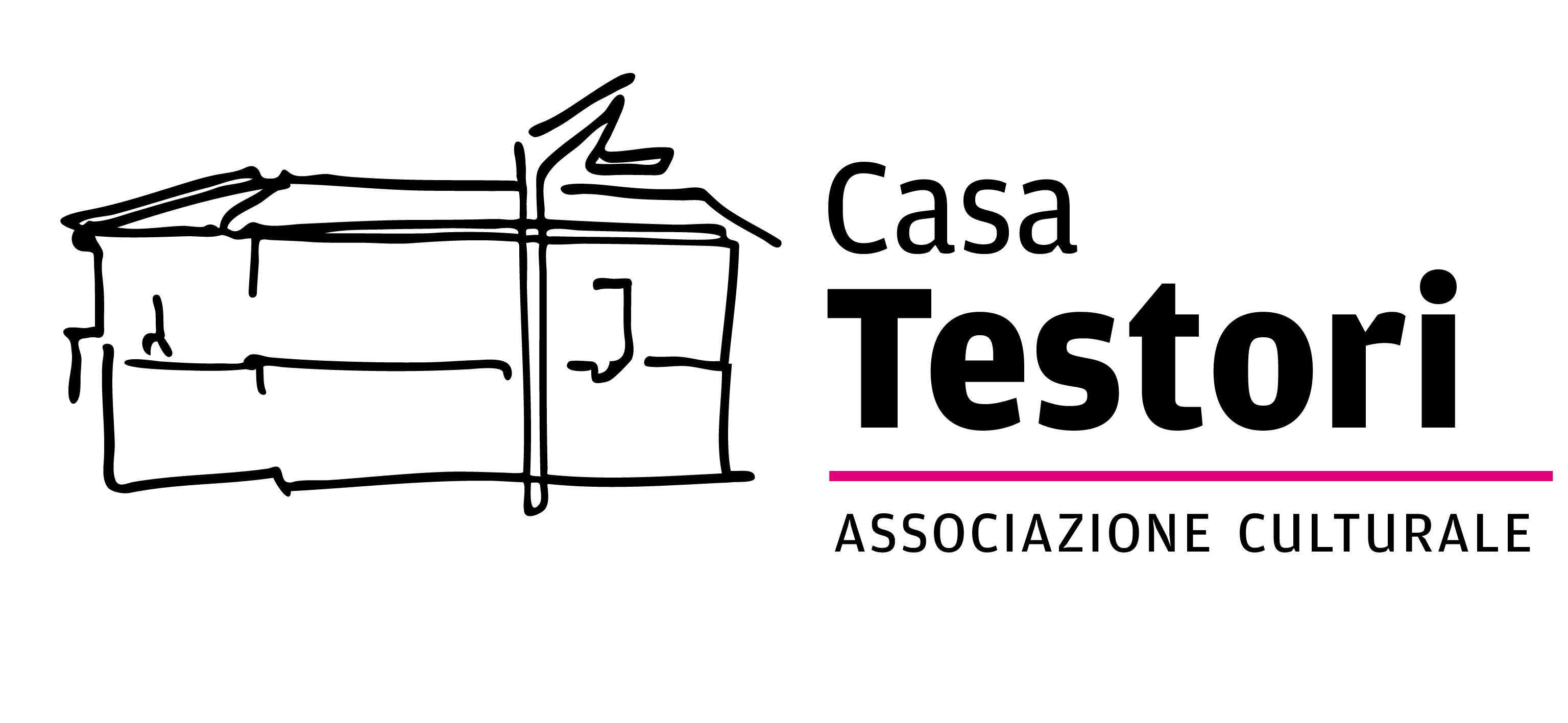SONO LE COSE CHE SIAMO – MENDINI
Alessandro Mendini a Casa Testori ha scelto la stanza 20. Una stanza dal significato e dal valore particolare, perché era la stanza di Testori, quella che si affaccia con il suo terrazzo circolare sul giardino. Nel corso di Giorni Felici il grande designer ha gentilmente accettato di dialogare in un incontro con il pubblico. Un incontro bellissimo che si è tenuto nello spazio magico del giardino con lo sfondo dello sferragliare violento dei treni.
Eccovi una trascrizione del dialogo con Mendini.
Partiamo dalla domanda più ovvia. Perché la sua scelta è caduta proprio su questa stanza. In fondo appartiene a quella parte della casa che venne aggiunta negli anni 30, con uno stile architettonico che sembra molto diverso da quello che conosciamo come suo. Il progetto è di un architetto in pieno stile Novecento, Antonio Cassi Ramelli…
Alessandro Mendini: Cassi Ramelli in realtà è stato proprio il mio professore. Ai tempi era considerato un terribile reazionario. perché lavorava con le colonne e con gli ordini classici mentre nel resto del mondo si lavorava all’insegna del funzionalismo e il razionalismo. Molto dopo, quando è spuntato il postmodernismo, e le colonne sono tornate in auge, pur con un altro sguardo e una altro metodo, c’è stata una rivalutazione di Cassi Ramelli. Qui essendomi stata data una possibilità di scegliere in quale ambiente mettermi, mi è sembrata molto interessante questa bow window senza vetro: una strutturina un po’ fascista ma di grande qualità classica, sul quale si affaccia lo studio di Testori. Mi è sembrato un luogo magico dove mettere un mio oggetto. Dentro la stanza mi sono limitato a mettere decorazioni molto fluide e molto semplici. Io ero un grande lettore di Testori. Mi affascinava questa sua capacità di affrontare tematiche di grande respiro a livello religioso e politico. Lo vedevo in parallelo con Pasolini. Sono sempre stato affascinato sia dalla sua capacità di leggere la pittura del 600 e della Controriforma sia dal suo modo di pitturare. il mio lavoro infatti è sempre nato non dall’architettura ma dalla pittura, da Carrà, Funi e Sironi. In questo posto ho trovato un fascino, anche urbanistico, un luogo dei quel fuori Milano, che in genere vediamo come un grande sfascio. Mi ha colpito la vicinanza gemellare con la ferrovia con quel suono antico che è ben diverso da quello delle tangenziali. Poi c’è il giardino, che è una specie di magia dietro la casa, rinserrato dallo stabilimento che è un segno della cultura di questi luoghi. Tutto questo determina un microclima che mi sembra molto importante venga conservato e rivitalizzato in questo modo con queste stanze riportate all’attualità dell’arte contemporaneissima.
Lei sta completando un progetto proprio qui vicino alla Bovisa. Cioé in una zona in grande trasformazione, ma dove si vedono ancora i segni pesanti dello sfascio urbano di cui lei parlava. Come ci sente nei panni di disseminatori di perle nel caos urbano?
Mendini: Oggi abbiamo a che fare con città che sono un grande patchwork. Le metropoli hanno lo sfascio segnato nel loro destino. Sono insiemi disarticolati, dove è durissimo rintracciare una logica urbana. Una volta chi faceva il mio mestiere lavorava per sintesi, oggi si va avanti per assemblaggi, per spezzoni. Il meglio che si può fare è puntare su piccole cose, nella consapevolezza che sono mini rimedi.
Come definirebbe oggi il mestiere di designer?
Mendini: Quando le mie figlie mi chiedevano che mestiere facessi, restavo interdetto, non sapevo cosa rispondere.
Proviamo con una definizione classica: il designer è un artista che lavora a prodotti destinati a una scala industriale…
Mendini: Anche questo non è del tutto vero. Dalla mia esperienza ho verificato che in un lavoro meno si guadagna e più soddisfazioni si hanno. Quando un tuo oggetto produce tanto denaro, inizia l’assedio dei vincoli che ti bloccano a livello creativo. Il designer è solo una metà dell’oggetto. L’altra metà è l’impresa, che ha logiche sue e per forza differenti. Io ho avuto la fortuna di lavorare con produttori talmente raffinati e disponibili che mi hanno sempre permesso di fare cose interessanti: a me piace lavorare su cose che sfuggono ad ogni definizione. Una poltrona che non è una poltrona…
A lei piace innovare e andare controcorrente. Eppure nel 2002 ha ammesso di avere riferimenti culturali molto classici. le riporto questa sua ammissione: «Gli autori fondamentali del passato cui guardo sono Vitruvio, Giotto, Piero della Francesca, le suore di clausura. Situazioni legate alla sapienza oggettiva. Dopo di che, man mano che ci avviciniamo a noi, il terreno diventa labile». Come ce lo spiega?
Mendini: Quando uno ragiona anche su quello che si fa come progettista, alla fine si arriva sempre sull’impianto stesso della vita. Rimangono fisse poche parole molto semplici e stabili: la vita, la morte, l’amore, il dolore. È la profondità del senso del vivere che entra in gioco e che questi autori hanno al centro della loro visione. Il nostro mondo invece è tutto sbilanciato sull’estroversione comunicativa. Anch’io mi ci metto. Non si fa una cosa senza che tutti gli altri la conoscano immediatamente. Io stesso cerco di nascondere quel che faccio, ma non ci riesco. In questo contesto mi trovo spesso a pensare alle suore di clausura, esseri molto spirituali che non si vedono e di cui però si percepisce la presenza senza che abbiano nessuna necessità di comunicarla.
Prendendo la direzione di Domus lei sotto la testata ha messo questa definizione: «La nuova utopia». Che cos’è questa “nuova utopia”?
Mendini: Ogni volta che ho preso la direzione di una rivista mi sono sempre imposto di seguire un’ideologia precisa, che non era mai la stessa. Questa volta mi sono detto: proviamo a ragionare su quali possano essere le nuove utopie. Ho lanciato la proposta a tutti personaggi con cui la rivista interloquisce e ciascuno risponde secondo il suo sentimento e il suo interesse. Alla fine mi piacerebbe capire se c’è spazio per tracciare un profilo di un’utopia comune.
Un esempio di risposta ricevuta?
Mendini: Mi è piaciuta quella di Mari. Ha detto che per lui l’utopia è un corrimano, un aiuto pratico per raggiungere degli obiettivi progettualmente etici. E per lei? Mendini: Sto cercando l’utopia nel modo dell’affrontare l’abitare. Oggi l’interno della casa è diventato un fatto esteriore superficiale. Ci sono degli standard che si trovano ai saloni del mobile o alla Rinascente o all’Ikea con cui si organizzano le funzioni di un vivere tutto esteriore. Ma l’abitare è un fatto molto profondo, un fatto psichico.
Non rischia di essere un’utopia solo per chi può permettersela?
Mendini: Alta o bassa borghesia è un problema per tutti. Ci può benissimo essere uno studente che lungo la ferrovia ha allestito una sua stanza e ci sta bene, con pochi soldi. Per fare una bella casa uno deve capire l’interno di se stesso. L’interno della casa è chance di autocreatività e di autocelebrazione. Del resto una persona è un’entità importante in sé. E merita di avere una casa che la rappresenta. Ricordo di una ragazza di una famiglia ricca che aveva deciso di vivere con solo 25 oggetti. Presi con lei un the, seduto per terra al centro di un salone bellissimo, usando la stessa bellissima tazza. Era la “sua” casa.
Lei di oggetti in mostra, alla Triennale, ne ha messi ben 800, però…
Mendini: Per la precisione sono 786. Sono le cose della mia vita. Che non sono solo oggetti e non sono necessariamente prodotti di design. Le cose sono quella specie di pulviscolo che ciascuno ha attorno a sé, legate a motivazioni mitiche, sentimentali, psicologiche. Le cose non necessariamente servono a qualcosa. Sono presenze. Sono le cose che siamo.
Posted on: 22 Luglio 2010, by : admin